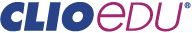Ordina
N. 2025/2 - Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management
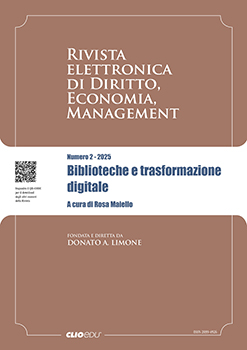
Numero 2 - 2025
Biblioteche e trasformazione digitale
A cura di Rosa Maiello
Biblioteche e trasformazione digitale: è il titolo di questo volume dedicato alle biblioteche considerate nel processo di trasformazione e transizione digitale. Il volume è curato da Rosa Maiello (avvocato; dal 2004 è direttore delle Biblioteche dell’Università di Napoli Parthenope) l’idea di dedicare un numero speciale alle biblioteche è stata di chi scrive; mi sono rivolto all’amico professore Gianni Penzo Doria per una indicazione su chi avrebbe potuto curare il numero della Rivista su questo argomento; il nome che Gianni mi indicò è stato quello di Rosa Maiello. Ringrazio Rosa Maiello per avere curato il numero con grande passione e scienza; il prof. Gianni Penzo Doria per avermi dato la migliore indicazione; ringrazio gli Autori per i contributi dedicati al tema.
Il risultato di questo lavoro: il lettore saprà giudicare con “facilità” perché gli Autori sono specialisti del settore, perché i contributi sono di grande attualità, perché le bi- blioteche svolgeranno nel futuro un ruolo istituzionale e sociale particolarmente innovativo. Resta valida la definizione di “biblioteca” data dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 42/2004, art. 101): “una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;….”. Ma questa definizione dovrà essere “riconsiderata” in nuovo contesto: quello della trasformazione digitale (con una grande estensione e valorizzazione dei concetti di raccolta, valorizzazione, gestione, consultazione, dif- fusione capillare, creazione di contenuti e di accesso ai sistemi digitali bibliotecari). Nella Prefazione Flavia Piccoli Nardelli (Presidente dell’Associazione delle Istitu- zioni di Cultura Italiane – AICI) con chiarezza introduce alla lettura di questo volume. “Le biblioteche, fin dalla loro prima diffusione costituiscono un luogo in cui la memoria individuale e collettiva si fa parola condivisa, patrimonio vivo, ponte fra differenti generazioni. Nell’Italia contemporanea – la cui ricchezza di patrimonio culturale sia materiale che immateriale è strettamente legata alla pluralità dei suoi territori e delle sue città – esse rappresentano la più capillare infrastruttura di democrazia cognitiva, anche se il quadro generale, come ricorda l’indagine ISTAT richiamata da Rosa Maiello, denuncia vistose lacune territoriali e di insufficiente presidio professionale. Nasce da questa consapevolezza l’urgenza di riflettere sulla necessità di trovare nuove forme di promozione della lettura e su come rilanciarne il progetto pubblico di un servizio bibliotecario diffuso alla luce delle sfide sociali, tecnologiche e ambientali che attraversano il nostro tempo”.
Rosa Maiello (Servizi bibliotecari e uso pubblico della ragione), curatrice del numero, parte dalla indagine ISTAT sulle biblioteche italiane che evidenzia come, da 2 un lato, nel loro insieme questi istituti siano il servizio culturale più diffuso e usato di tutti e, dall’altro, come la presenza di biblioteche e di bibliotecari sia drammaticamente insufficiente, soprattutto al Sud. Alcune recenti misure normative - come il “Piano Olivetti” per la cultura e, precedentemente, la legge 15/2020 - sembrano voler portare al centro dell’attenzione il ruolo delle biblioteche per la civiltà. Nell’epoca della trasformazione digitale, la rilevanza delle biblioteche per l’uso pubblico della ragione può essere riaffermata, ma occorre investire sulle biblioteche e sulla formazione di una generazione di bibliotecari capaci di governare il cambiamento.
Claudio Leombroni (Le biblioteche pubbliche dell’Italia contemporanea fra istituzione e rappresentazione) si sofferma sulla “trama” concettuale e istituzionale riguardante le biblioteche pubbliche e ne ricostruisce sinteticamente lo sviluppo a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, interpretandone le traiettorie evolutive, così come le invarianze, come risultato del rapporto fra quadro istituzionale e mutamento sociale e culturale. Il rapporto fra processi di istituzionalizzazione della biblioteca pubblica italiana e la sua rappresentazione sociale consente di scorgere nel ‘campo bibliotecario’ un costante conflitto nel definire cosa sia una biblioteca e quali bisogni essa soddisfi o possa soddisfare.
Liù Palmieri (Le sfide della prossimità) rileva che da qualche anno le biblioteche di tutto il mondo stanno vivendo un epocale cambiamento di paradigma, da istituzioni squisitamente documentali a piattaforme di comunità. Questo presuppone un deciso cambio di postura ispirato soprattutto dalla dimensione della prossimità, non solo geografica, ma anche relazionale e sociale. Scopo dell’articolo è illustrare come le Biblioteche del Comune di Milano si stanno attrezzando per dispiegare tale strategia assecondando le specificità locali e adottando strumenti e approcci il più possibile innovativi rispetto al modus operandi tradizionale della Pubblica Amministrazione.
Il contributo di Stefano Parise (Prove di contemporaneità. Come le biblioteche di Milano cambiano la città). Le biblioteche pubbliche stanno rielaborando il proprio ruolo per adattarlo alle sfide della contemporaneità, al fine di non perdere rilevanza. Ciò comporta la capacità di riorientare gli strumenti tipici di un istituto millenario verso nuove sfide e a supporto di pubblici portatori di attitudini e bisogni che costringono a rivedere certezze, approcci, strumenti e competenze. Questo contributo illustra l’approccio seguito dalla città di Milano per riprogettare il servizio bibliotecario su scala di quartiere e metropolitana, prendendo a riferimento due casi esemplari: quello della Biblioteca rionale Chiesa Rossa e quello della BEIC (Biblioteca Europea di Informazione e Cultura).
Di Rossana Morriello un articolo sul “digitale” ed il sistema bibliotecario (Le collezioni digitali delle biblioteche: prospettive, sviluppo, criticità). Lo sviluppo delle risorse digitali come parte essenziale delle collezioni delle biblioteche, a cominciare 3 da quelle delle università, è avvenuto a partire degli anni Novanta del secolo scorso. Tale svolta si collocava in un’epoca di trasformazione della società da molti punti di vista. Le biblioteche delle università fecero da apripista a molte innovazioni e trasformazioni, con impatto sulle caratteristiche dei servizi e delle specializzazioni necessarie. La principale di queste è il passaggio dal possesso all’accesso, da collezioni acquisite al patrimonio permanente della biblioteca a collezioni costruite in base a licenze d’uso, più o meno permissive: una criticità che ha innescato la spinta verso l’accesso aperto alla letteratura scientifica. In anni recenti comincia a profilarsi un ulteriore approccio: le collezioni come dataset da cui estrarre valore mediante applicazioni di intelligenza artificiale. Guardare alle collezioni come set di dati significa puntare non tanto alla discoverability della singola risorsa, ma piuttosto a sviluppare i legami e le relazioni tra le risorse, selezionando gli strumenti appropriati per rendere la collezione computabile.
Laura Ballestra (Il ruolo delle biblioteche per l’information e Media Literacy e la cittadinanza attiva). Il mondo delle biblioteche ha conosciuto negli ultimi cinquant’ anni continue evoluzioni tecnologiche e ha reagito alle opportunità offerte dai cambiamenti occorsi nel mondo dell’informazione creando ambienti ibridi, dove biblioteche fisiche coesistono con biblioteche digitali e le collezioni vengono organizzate in modo funzionale ai differenti fini e ai bisogni delle comunità servite. A fronte del continuo crescere della complessità degli universi informativi la funzione di consigliare e orientare alla scelta di informazione, tradizionalmente parte dei servizi di biblioteca, è divenuta sempre più centrale, come pure la capacità di educare ad un uso consapevole della documentazione rilevante e autorevole. IFLA, International Federation of Library Association, ha coniato il termine “Media and Information literacy” per indicare la capacità dei singoli di ricercare, selezionare, leggere e apprendere a partire da informazione rilevante. In una Società dell’informazione, oggi delle intelligenze artificiali, le sfide di contesti informativi sempre più complessi e sempre meno comprensibili rendono le biblioteche, che operano da sempre per la selezione della documentazione e per l’educazione ad un uso critico e consapevole, un caposaldo tra le istituzioni che favoriscono la crescita personale e sociale dei cittadini attraverso la ricerca e la lettura di informazione di qualità.
L’articolo di Vittorio Ponzani (Il servizio di reference e l’informazione di qualità (anche) per la salute dei cittadini) su di un tema di grande rilevanza sociale, scientifica, tecnica ed economica. Il servizio di reference è lo strumento di mediazione informativa per far incontrare l’utente, con le risorse documentarie possedute dalla biblioteca e può essere considerato una componente essenziale dell’information literacy, cioè la capacità di cercare, valutare e utilizzare le informazioni in modo critico e consapevole. Nell’ambito della salute questo è particolarmente importante perché informazioni inaffidabili, non aggiornate o errate possono avere conseguenze anche gravi sulla vita delle persone.
Un tema particolare è quello affrontato da Fernando Venturini (La biblioteca parlamentare tra crisi della rappresentanza e società dell’informazione: un’istituzione “in cerca di autore”). L’articolo parte dalla crisi della rappresentanza politica e dell’istituzione parlamentare per poi approfondire, in modo particolare, il tema della funzione conoscitiva del Parlamento e il rapporto tra mondo della conoscenza e politica, cioè, in definitiva, il rapporto tra tecnica e politica. La biblioteca parlamentare ha avuto un ruolo nella storia della funzione conoscitiva del Parlamento in relazione alle diverse epoche storiche. Con la crisi del partito politico, il rafforzamento dei governi e l’indirizzo politico derivante dalle organizzazioni internazionali o sovranazionali, si restringono i margini di autonomia dei parlamenti. Progressivamente, la biblioteca parlamentare ha ceduto competenze ed è stata affiancata da apparati di ricerca sempre più specializzati. Si sono indebolite le funzioni tradizionali di supporto al legislatore o di biblioteca privata del parlamentare. Le biblioteche parlamentari che hanno una lunga storia e collezioni consistenti devono reinventare il proprio futuro, spostando il baricentro dalla documentazione alla comunicazione oppure cercando una collocazione nel panorama bibliotecario nazionale. Una delle prospettive più interessanti è quella della biblioteca del Parlamento intesa, insieme agli Archivi storici parlamentari, come “specchio dell’istituzione”, proiezione esterna a supporto della cultura storica e istituzionale e dell’educazione alla cittadinanza attiva.
Lorenzana Bracciotti e Alberto Salarelli (Il ruolo strategico delle biblioteche nazionali nella conservazione del web) affrontano il tema del web archiving, i soggetti coinvolti (archivi o biblioteche) e l’istituto del deposito legale, evidenziando come le biblioteche nazionali siano fondamentali per la raccolta, conservazione e accesso alle risorse digitali. Il loro ruolo nel web archiving e nel deposito legale contribuisce alla preservazione e fruizione del patrimonio culturale digitale, garantendo l’accesso sostenibile per le generazioni future.
E non poteva mancare una riflessione sul rapporto tra biblioteche ed intelligenza artificiale (Verso il futuro: l’impatto trasformativo dell’intelligenza artificiale nelle biblioteche) di Antonella De Robbio. L’impatto dell’Intelligenza Artificiale (IA) sulle funzioni istituzionali, culturali e sociali delle biblioteche sta ridefinendo le strategie operative, fornendo strumenti innovativi per l’erogazione di servizi avanzati. Nel contesto istituzionale, l’IA sta rivoluzionando la gestione documentale, permettendo una categorizzazione più efficiente e una ricerca più accurata delle risorse. Per le biblioteche di pubblica lettura, sotto il profilo sociale, l’IA promuove un coinvolgimento più dinamico delle comunità locali, adattando i servizi bibliotecari alle esigenze specifiche del pubblico. La personalizzazione dell’esperienza utente, resa possibile dall’analisi predittiva dell’IA, trasforma le biblioteche in spazi interattivi e inclusivi. Culturalmente, mentre nell’ambito della convergenza MAB (Musei, Archivi e Biblioteche), l’IA si presenta come un alleato prezioso nella conservazione del patrimonio, facilitando la digitalizzazione e la preservazione di documenti antichi e materiali rari, nelle biblioteche accademiche e di ricerca, l’IA emerge in modo dirompente, nelle varie attività entro le missioni istituzionali. La tecnologie IA possono migliorare non solo le missioni tradizionali di insegnamento e ricerca, ma agendo anche come catalizzatore per la terza missione, contribuendo attivamente allo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità in cui sono inserite. In sintesi, questo articolo illustra l’evoluzione delle biblioteche come centri di innovazione digitale, evidenziando il potenziale positivo dell’IA nell’ottimizzazione dell’esperienza degli utenti interni, contribuendo contemporaneamente a una maggiore trasparenza e accessibilità informativa per il pubblico esterno.
Come direttore e fondatore della Rivista sono particolarmente lieto della produzione di questo numero speciale perché sicuramente stimolerà la riflessione e le decisioni pubbliche per un nuovo ruolo delle biblioteche come ecosistemi culturali digitali per la diffusione e la produzione della informazione di qualità e l’accesso più esteso possibile ai sistemi di conoscenza determinanti per lo sviluppo consapevole del nostro sistema sociale.
Questo numero monografico si pone come un contributo concreto a supporto del “Piano Olivetti per la cultura” di cui all’art. 1 della Legge 16/2025, nella logica di un intervento organico, sistemico, sostenibile.